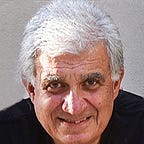Alla ricerca del muretto giallo
La “Veduta di Delf” di Vermeer nella “Recherche” di Proust
Nell’opera di Proust Vermeer è menzionato 11 volte contro le 6 di Leonardo, le 11 di Botticelli e le 13 di Rembrandt. È forse l’artista più presente, benché vi siano moltissime digressioni artistiche nell’opera dello scrittore francese.
Vermeer ha un legame strettissimo con due personaggi centrali del romanzo: Charles Swann che è anche uno studioso del pittore olandese, seppur non ha mai completato il suo studio, e lo scrittore e critico Bergotte che muore proprio di fronte alla Veduta di Delf.
Questo episodio del romanzo porta una traccia autobiografica. È il malessere sofferto da Proust nel 1921 durante la sua visita a una mostra sui pittori olandesi nella quale è esposto anche la Veduta di Delf.
Oltre che in occasione del malore di Bergotte, la Veduta di Delf è menzionata in un altro passo de La prigioniera. Siamo nel salotto di Monsieur de Guermantes Marcel pronuncia queste parole:
Dissi che stato una volta ad Amsterdam e all’Aia, ma che per non fare troppa confusione, visto che il mio tempo era limitato, non ero andato ad Haarlem. «Ah! l’Aia; che museo!» esclamò M. de Guermantes. Gli dissi che certo aveva ammirato la Veduta di Delft di Vermeer. Ma il duca era più orgoglioso che istruito, così si limitò a rispondermi con aria di sufficienza come ogni volta che gli si parlava di un’opera, di un museo o anche del Salon di cui non si ricordava: «Se era da vedere, l’avrò visto».
La morte di Bergotte
Venni a conoscenza, quel giorno, di una morte che mi recò un grande dolore: quella di Bergotte. È noto che la sua malattia durava da tempo. […]
La morte di Bergotte sopraggiunse l’indomani di un giorno in cui si era affidato a uno di quegli amici, un amico (o nemico?) troppo potente.
Morì nelle circostanze seguenti: a causa di una crisi d’uremia abbastanza leggera gli era stato prescritto il riposo. Ma, avendo letto l’articolo di un critico d’arte in cui si diceva che nella Veduta di Delft di Vermeer(prestata dal museo dell’Aja per una mostra di pittura olandese), quadro che lui adorava e riteneva di conoscere a fondo, un breve scorcio di muro giallo (di cui Bergotte non si ricordava) era dipinto così bene che, se lo si astraeva dal resto pareva una preziosa opera d’arte cinese, di una bellezza che poteva bastare a se stessa, Bergotte mangiò delle patate, uscì e andò alla mostra.
Fin dai primi gradini che ebbe a salire, fu colto da vertigini.
Passò davanti a parecchi quadri, e avvertì l’aridità e inutilità di un’arte così artificiosa che non valeva le correnti d’aria e di sole di un palazzo di Venezia o di una semplice casa in riva al mare.
Infine, giunse davanti al Vermeer che ricordava più sfolgorante, diverso da tutto ciò che conosceva, ma dove, grazie all’articolo del critico, notò, per la prima volta, dei piccoli personaggi blu e che la sabbia era rosa e, infine, la preziosità della materia di quel breve scorcio di muro giallo.
I suoi giramenti di testa aumentavano; lui fissava lo sguardo sul prezioso scorcio di muro, come un bambino fissa una farfalla gialla che vuol catturare.
«È così che avrei dovuto scrivere,» si diceva «i miei ultimi libri sono troppo secchi, avrei dovuto stendere più strati di colore, rendere la mia frase più preziosa come quel breve scorcio di muro giallo.»
Tuttavia non gli sfuggiva la gravità dei suoi giramenti di testa. In una celeste bilancia gli appariva su un piatto la sua vita, sull’altro quel breve scorcio di muro così ben dipinto in giallo. Sentiva di aver imprudentemente dato la prima per il secondo.
«Non vorrei,» si disse «essere per il giornale della sera il fatto di cronaca di questa mostra.» Si ripeteva: «Breve scorcio di muro giallo con tettoia, breve scorcio di muro giallo». In quell’istante cadde su un divano circolare; all’improvviso smise di pensare che era in gioco la sua vita e riprendendo il suo ottimismo, si disse: «È una semplice indigestione dovuta a quelle patate non abbastanza cotte, non è niente».
Un nuovo colpo lo abbatté, rotolò a terra, accorsero i visitatori e i custodi. Era morto. Morto per sempre? Chi può dirlo? Certo, né le esperienze spiritiche né i dogmi religiosi provano che l’anima sopravviva. Si può solo dire che nella nostra vita tutto accade come se vi entrassimo con un fardello di obblighi contratti in una vita anteriore; non c’è alcuna ragione, nelle nostre condizioni di vita su questa terra, perché ci si debba sentire obbligati a fare il bene, a essere delicati, o anche semplicemente cortesi, né perché un artista ateo si senta in obbligo di rifare venti volte un pezzo che, se susciterà ammirazione, essa importerà ben poco al suo corpo mangiato dai vermi, come il breve scorcio di muro giallo dipinto con tanta sapienza e raffinatezza da un artista per sempre sconosciuto, appena identificato sotto il nome di Vermeer.
Tutti questi obblighi, che non hanno la loro sanzione nella vita presente, sembrano appartenere a un altro mondo, fondato sulla bontà, lo scrupolo, il sacrificio, un mondo completamente diverso da questo e dal quale usciamo per nascere a questa terra, prima forse di ritornarvi sotto il dominio di quelle leggi sconosciute alle quali abbiamo obbedito perché ne portavamo in noi gli insegnamenti, senza sapere chi le avesse promulgate — quelle leggi cui ci avvicina ogni lavoro profondo dell’intelligenza e che rimangono invisibili soltanto agli sciocchi e, forse, nemmeno a loro.
Di modo che l’idea che Bergotte non fosse morto per sempre, non è del tutto inverosimile. Venne alla fine sepolto, ma per tutta la notte della veglia funebre, nelle vetrine illuminate, i suoi libri, disposti a tre a tre, vegliavano come angeli dalle ali spiegate, e sembravano, per colui che non era più, il simbolo della sua resurrezione.
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Rizzoli, Edizione del Kindle, pp. 2799-2801