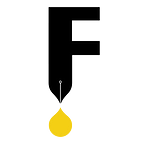La Pausa
di Tonia Peluso, da VIVA un quindicinale di Fantastico!
«C’è un tempo perfetto per fare silenzio
Guardare il passaggio del sole d’estate
E saper raccontare ai nostri bambini quando
È l’ora muta delle fate»Ivano Fossati — C’è tempo
Con pausa s’intende in genere una sosta, una fermata, l’interruzione temporanea, più o meno breve, di un’attività destinata a riprendere. La pausa, per sua stessa natura, richiede che vi sia continuità. La sua esistenza ha come condizione imprescindibile la presenza di un prima e un dopo in cui andarsi a posizionare. La pausa non divide, anzi unisce. In musica la pausa è una “cessazione temporanea del suono, che può cadere in qualsiasi momento della composizione musicale, e avere diversa importanza a seconda della sua durata e della sua posizione ritmica” (Treccani). Non è un elemento disturbante, è parte della composizione e contribuisce alla sua armonia. Quando parliamo, recitiamo o leggiamo facciamo delle pause che ci permettono, di volta in volta, di dare un tono diverso a ciò che stiamo dicendo. Le pause, insomma, sono un elemento importante della nostra esperienza quotidiana anche se oggi rischiano di essere viste come tempo perso a far nulla in una società che, al contrario, richiede di correre veloce, spesso senza neanche sapere dove andare. Le pause sembrano essere diventate anacronistiche. Non c’è più posto per la lentezza rituale che accompagnava gran parte dei passaggi sociali epoche addietro. Stiamo vivendo una rinegoziazione del significato del tempo, che ha ricadute significative sull’identità di ciascuno. Viviamo, senza neanche renderci conto, una perdita di senso del tempo, che toglie valore al passato e distrae dalla prospettiva futura, portandoci a vivere un presente che si ripete ogni volta, con la pretesa di diventare eterno. L’esperienza del momento prova a insinuarsi nelle nostre vite come valore preponderante, svuotando di ogni importanza l’esperienza. Siamo ancora capaci di distinguere l’essenziale dal superfluo, il durevole dall’effimero? La nostra identità di persone, che si costruisce attraverso un progetto di vita, è ancora capace di immaginare un progetto continuo o rischia di essere messa ogni volta in discussione, riaggiornata in base alle esigenze immediate, assemblata e disassemblata come un pacchetto pay-per-view?
In Vite di corsa — sottotitolo significativo Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero — Zygmunt Bauman prova a dare delle risposte a riguardo.
«Nella società dei consumi della modernità liquida il tempo non è né ciclico né lineare, come normalmente era nelle altre società della storia moderna o premoderna. Intendo mostrare che esso è invece puntillistico, ossia frammentato in una moltitudine di particelle separate, ciascuna ridotta a un punto che sempre più si avvicina all’idealizzazione geometrica dell’assenza di dimensione. Come certamente si ricorda dalle lezioni di geometria a scuola, i punti non hanno lunghezza, larghezza o profondità. Essi esistono, si è tentati di dire, prima dello spazio e del tempo, quando sia lo spazio che il tempo devono ancora avere origine.»
Secondo il sociologo polacco, quindi, percependo il tempo come puntillistico, stiamo perdendo la capacità di trovare un senso nel passato alle nostre azioni, così come diventa difficile porre le basi per la realizzazione di progetti futuri. Il rifiuto dell’esperienza, vista come obsoleta, unito all’assenza di progettualità, divenuta impossibile a causa di una precarietà esistenziale e di un consumismo feroce, ci inducono a vivere di corsa. Ogni esperienza è un punto isolato dagli altri. Ogni punto è un’occasione da cogliere a volo o perdere per sempre. Non ci sarà una seconda occasione, ma potranno esserci tanti nuovi inizi. Eppure, ogni nuovo inizio avrà una fine, una data di scadenza programmata o comunque inevitabile affinché ci si possa dedicare a nuovi inizi, altre occasioni, esperienze diverse, che a loro volta finiranno. Nulla sembra destinato a durare per sempre nella società delle false partenze che illudono senza soddisfare.
Per poter ripartire ogni volta bisogna però prima fare un passo pericoloso: dobbiamo disabilitare il passato. Si ha la necessità di rinnegare tutto ciò che abbiamo vissuto e, possibilmente, anche i valori e le emozioni che ci hanno accompagnato, così da essere individui nuovi, pronti a rinascere. Dimenticata la fugacità della vita, che passava veloce senza troppe possibilità di cambiamento, oggi crediamo di poter vivere e comprimere molte vite, grazie ai nuovi inizi che annullano le vite precedenti. Si ha quasi la sensazione di essersi avvicinati a un’onnipotenza di stampo divino. Cosa non si può fare cancellando il passato? Possiamo rinascere, diventare persone diverse — non per forza migliori — magari seguendo il modello che va per la maggiore. Migliorare sé stessi pare diventato un concetto obsoleto, uno sforzo inutile non adatto a una società in cui le cose rotte non si aggiustano, si buttano. E così anche la nostra identità diventa un progetto da resettare e riprogrammare di volta in volta, senza compiere lo sforzo di migliorarsi.
«Cancellare il passato, rinascere, acquisire un sé differente, reincarnarsi in qualcuno completamente diverso… è difficile resistere a queste tentazioni. Perché mai lavorare per migliorare sé stessi con tutti gli strenui sforzi e i dolorosi sacrifici che un tale arduo compito notoriamente richiede? Perché buttare soldi al vento? Non è più conveniente, più rapido, più esaustivo, più opportuno e più facile annullare le perdite e ricominciare? Gettare la vecchia pelle, con le sue macchie, i suoi nei o ogni altra imperfezione, e comprarne una nuova? Non c’è niente di nuovo nel cercare la fuga quando la situazione sta diventando veramente difficile. La gente ci ha sempre provato. Ciò che è nuovo è la prospettiva di un leopardo che si cambia le macchie, il sogno di fuggire da sé stessi unito alla convinzione di poterlo realizzare; non è solo un’opzione tra molte, ma l’opzione più facile, quella che probabilmente funzionerà meglio in caso di guai. Una scorciatoia, un’opzione meno gravosa, che richiede meno tempo ed energie, e quindi a conti fatti risulta più conveniente.» scrive ancora Bauman.
Correre serve a sfuggire, anche da sé stessi. Le pause servono a restare.
La pausa permette di creare uno stallo nel tempo lineare, uno spazio da cui poi riprendere. Non è conclusione, unisce. Ci fermiamo per capire cosa non stia funzionando. Prendiamo tempo per aggiustare il tiro e ripartire. Respiriamo per recuperare. La pausa diventa, in una società che va avanti e dimentica, il ponte che tiene insieme esperienze diverse e pezzi di noi stessi che parrebbe meno gravoso lasciar andare in frantumi.
Io, a esser sincera, a volte fatico a gestire le pause. O meglio, mi è difficile declinare nella forma giusta il verbo aspettare. Vado di fretta o rischio di fermarmi per periodi lunghi. Quando mi alleno, per esempio, ho fretta di ripartire. Invece di respirare cammino, mentre chiedo impaziente: «Vado?». Poi mi accorgo che mi manca il fiato, che sarebbero bastati 10 secondi di recupero in più per evitare che il respiro mi si strozzasse a esercizio in corso. Avrei dovuto fare una pausa di poco più lunga per evitare di dover ricominciare daccapo. In altre situazioni, al contrario, ho preso pause troppo lunghe, mi sono messa in stand by aspettando le condizioni giuste. Ma ormai, quando sembravano finalmente esserci, non era più tempo. Prossimo giro, prossima corsa.
Proprio in questi giorni una pausa non voluta mi ha messa in crisi. Stavo avanzando la pretesa di continuità in un percorso che richiede costanza e pazienza, ma soprattutto accettazione di tempi che a volte sembrano inutili e hanno, invece, il loro motivo di esistere all’interno di un progetto completo: le pause, appunto. Mi ha tirata fuori un «È normale, che pretendi», che quando l’ho sentito, a dire il vero, mi ha fatto venir su un nervoso che mi ha portato via anche la voglia di spiegare cosa per me non fosse normale invece. Eppure, in quel momento lì, in quella frase a me così indigesta, c’era una verità grande che ho rielaborato qualche ora — e molte scenate da prima donna — dopo: è normale fermarsi, le pause servono a conoscerci meglio. L’importante è ripartire, senza dimenticare la vita che abbiamo alle spalle.
Da sempre la mia pausa più grande è l’estate, a Napoli ‘a stagione.
«‘A stagione si esce, si perdono gli orari. ‘A stagione si vive. Si mettono da parte i problemi e si fanno le provviste di spensieratezza per l’inverno. ‘A stagione non esiste il vaccino, il covid, il lockdown. Non abbiamo addosso l’amarezza per i diritti civili negati, né la rabbia per la dignità calpestata. ‘A stagione, voi non ci crederete, ma scompare anche il precariato. Il lavoro a nero? Non esiste, ve lo giuro. È un tempo scellerato, allora penserete. È un tempo di eccessi, pericoloso. È l’invito a violare qualsiasi regola. No, è tutto il contrario. È il tempo sperato, è un tempo che si dilaziona fino a farti perdere e ti abbraccia, ti consola. È il tempo della vita che ti fa credere d’aver davanti un anno migliore. ‘A stagione, tra un tuffo e un tramonto, ti dà la forza di restare a galla»
scrivevo sul numero 9 di Viva circa un anno fa, augurandovi buone vacanze.
Vale lo stesso ora. Noi andiamo in vacanza.
Prendetevi tutte le pause che servono.
Ci leggiamo a settembre.