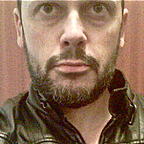L’anno della mia distopia
Immaginavano che un pronipote dal futuro sarebbe andato a disseppellirli?
Al bivio che lo sceneggiatore di Bandersnatch ha scritto per me, una volta trovatomi all’ingresso dello storico convento di San Francesco Fuori le Mura non proseguo diritto al museo civico, bensì volgo a sinistra. La targhetta recita Archivio Storico Comunale intitolato a Dino Renier, e prima di accedere alle scale che dominano uno degli accessi più belli alla città devo lasciarmi dietro la maniglia antipanico collegata a un sensore sonoro, il quale fa il suo dovere avvertendo chi sta sopra della mia presenza. Così insolito deve apparire, il rado avvicinarsi di umane spoglie fra i modelli dei bragozzi e le cassette di sicurezza: nell’anno che si è appena chiuso, quella porta è stata la mia botola di Mary Poppins, lo Stargate da cui essere risucchiati, la DeLorean che aspettavo dall’Ottantacinque, personale declinazione della dilagante distopia. Salendo quelle scale ho provato ogni volta, giuro ogni volta, il sollievo di lasciare il mondo fuori di sé, e l’ingordigia bambinesca davanti al chiosco delle caramelle. Ogni volta, ogni volta ho cercato di sbrigare i miei altri daffari il più in fretta possibile, per potervi attingere con ogni clima, fosse in bici col sole che irretisce la laguna del Lusenzo o la nebbia pannosa degli ultimi giorni: lavoro per lo più al mattino con incombenza quotidiana, e al pomeriggio l’archivio è purtroppo chiuso.
Vi ho messo piede perché da vicepresidente del locale comitato ANPI avevo la necessità di conoscere l’esatta ubicazione dell’ultimo domicilio noto relativo a un partigiano morto nel lager di Dachau dopo la fine della Seconda Guerra, dal momento che tra meno di un mese sarà messa a dimora la pietra d’inciampo che lo riguarda. Nemmeno sapevo che un archivio si trovasse lì, lo ipotizzavo in uno stabile poco distante ma diviso da un ponte, così come molti anni fa ero sicuro si trovasse al Granaio, in pieno centro storico. Né avevo contezza di quali documenti celasse, a quali periodi risalenti, se consultabili in libertà o sotto richiesta bollata, le infinite possibilità di augusto appagamento personale taciute ai più. In pochissimi davvero, di cinquantamila scarsi che abitiamo, sono a conoscenza del fatto che di lato al museo sta anche l’archivio comunale, storico per forza di cose: solo la valida quanto sparuta batteria degli storici locali è usa consultarlo, o la gioventù impegnata nelle tesi di laurea -spesso in Architettura- ad argomento cittadino. Ma partito da un bulimico colmare ogni lacuna, il continuo pellegrinaggio ha rivelato bisogni e curiosità che non pensavo di sopire in seno: la chiamano serendipità.
Quel giorno la solerte archivista volle illustrare a me e agli altri ospiti ciò che di prezioso era tenuto nello scrigno: indossò i guanti ed estrasse uno Statuto datato 1246, salvatosi miracolosamente dalla guerra contro i Genovesi e dall’incendio che devastò un precedente archivio all’inizio dell’Ottocento. E non era certo l’unica perla (potum sitientibus praebere): tra i corridoi sempre provvisori, scanalati da enormi porte scorrevoli di un blu poco solenne, stava non solo quanto serviva a individuare la casa del ribelle Guido Lionello, ma tutta Chioggia, i suoi soldati a Lissa, i naufraghi del Seicento e le levatrici alfabete, i mille morti del colera repubblicano e con quale medicamento sono state alleviate le loro sofferenze. Manifesti cubitali per la tessera del pane, atti processuali parrucconi senz’altro utili a scrivere le Baruffe, il censimento asburgico del 1857 dove andavano accatastati perfino fanti cani cavalli cani ed un somaro. I detti estinti, i nescio nomen prima dell’adozione, i sovversivi e le meretrici, numeri delle case cambiati nei mesi in cui il padre di Walter Veltroni, adolescente, sostò nei paraggi di mia nonna sua coetanea: la congettura ucronica che si siano conosciuti e piaciuti, sliding doors da vertigine per il Paese. Ed era tutto nelle mie mani, a volerlo.
Spiegai alla dottoressa le mie future intenzioni: da sempre interessato a venire a capo del cognome insolito di mia nonna (istroveneto di antica radice siriana e patrizio serenissimo, poi -mi disse un batanante mentre remava- consolidatosi nella Cicerìa interiore), per capire da quanti anni calpestiamo questi sassi e non quelli dell’altra riva, onde formulare una genealogia utile a celebrare i cent’anni dalla nascita della vècia Lidia Suriàn. L’archivista, di rara disponibilità oltre alla competenza, si offrì di svolgere per mio conto le prime ricerche, partendo dai dati cospicui di cui già disponevo («mio nono se ciamèva Felisse, mia nona Vissensa») riguardo alla quarta generazione, raccolti da mia madre per esperienza diretta o nei suoi conversari con mia nonna e col padre di lei. Non tardò ad arrivare la prima mail della stimata professionista, recante in dono le prime, fondamentali delizie: si appalesava -siamo a prima della metà dell’Ottocento- il cardine della quinta generazione, il primo a disporre di un bragozzo a nome proprio. E con lui, nonno di mia nonna morto anziano lo stesso anno della nascita della nipote, le specifiche essenziali afferenti ad un discreto nucleo di affini, consanguinei e omonimi, il mestiere quasi sempre uguale, la residenza nel giro di poche calli in uno stesso rione, la tranquilla certezza scritta che fossero tutti poveri.
Da allora presi a frequentare la biblioteca dell’archivio, in compagnia occasionale di studenti nell’alternanza scuola-lavoro o altri crononauti con le mie stesse velleità (ma un passato probabilmente meno complicato da ricostruire). Quando occorre, la custode di oltre settecento anni di storia mi porge il volume esatto, quello consequenziale, l’inventario donde mettere mano; mi siedo inspirando, per due o tre ore non voglio essere disturbato da alcunché non abbia a che fare con l’oggetto della ricerca. Sfoglio pazientemente tomi spessi dalle pagine incartapecorite, plasmate dai polpastrelli e dall’aria umida; compulso grafie di ufficiali dell’anagrafe, svolazzi Art Nouveau e prima ancora doppie zeta di foggia diversa. La tachicardia quando compare un avo, un cugino, un patronimico; la commozione di latte condensato al pensare che senza questo o quell’anello della catena biblica che sto ricostruendo, non sarei io ora a cercarne le tracce, ma un altro chi. E diventano davvero familiari quei quadrati di carta annerita, Niccola, Rocco, zia Felicita, Santa e Antonia nella cassa bianca degli angeli: li chiamo per nome e li posiziono nella griglia dello schema, calafati e cucitrici, barbe e tabarri. Uno struggimento pari all’husky che dice I love you o al ricciolo di note ricorrente nella Tosca, alla lettura del foglietto che una mattina di ottobre di centosessantun anni fa il messo comunale consegnò alla nonna del mio bisnonno, Rosa Penzo, per dispensare il figlio minorenne ma già pescatore dal pagamento delle tasse. La donna non firmò perché era analfabeta (il desiderio di non essere come tutti), ma ricevette lo stesso il documento dalle mani di questo giovane Andrea. L’avrebbero mai immaginato, l’una e l’altro, che un tizio del futuro sarebbe andato a disseppellirlo? E che quel medesimo pronipote ha vissuto a cinque portoni di distanza dal luogo della consegna?
Ben presto l’opera assunse rilievi ulteriori: dal compimento del puzzle delle mescolanze che ha portato fino a me, anzi ai figli delle mie cugine, a una collazione spontanea e casuale del genius loci, sotto forma di battesimi trasmessi dai nonni ai neonati nelle dinastie bottegaie, mode diventate disuso, leggende greche a emancipare i genitori dai santi del lunario, frazioni in via di ripopolo, migranti di ritorno, la devozione ai protettori della città, quasi obbligata se venivano al mondo due gemelli. Divagando, mi spinsi anche a considerare i tre possenti cassoni degli affari militari 1916–18, alla caccia di renitenti da premiare con gli onori postumi, restando abbagliato dalla carta velina inviata da chi ha perso un figlio in guerra, dalle suppliche di riavvicinamento rispetto al fronte per i padri quarantenni, dai gelidi telegrammi per comunicare che qualcuno era rimasto sul campo, lasciando due sigarette e dieci centesimi di regia lira. Va da sé che -per definizione- la ricerca non è mai terminata, è anzi il senso stesso del fare le cose: e a un certo punto dovrà chiedere venia ad un altro archivio, quello diocesano, che detiene le fragili pergamene di quando Colombo scopriva le Americhe e da queste parti la Madonna appariva a un contadino per ottenere (invano) che la città non bestemmiasse oltre.
Nel 1557 il cartografo Cristoforo Sabbadino disegna la città con le calli, la piazza, i tre canali, le chiese, le isole nelle isole. Nel 1762 Carlo Goldoni cammina verso Vigo e prende appunti dell’indole delle donne baruffanti, dei mocciosi che giocano a terra e sulla riva, delle autorità pacificatrici. Uguali le calli, la piazza, i canali, le chiese, le isole. Nel 2019 la Bianca e la Maria fanno la spesa con le sporte celesti, comprano i carciofi mondati dalla sióra Giovanna ai Filippini e passano il pomeriggio a giocare a tombola in un garage di calle Vescovi: ancora le stesse calli, la medesima piazza, i canali rimasti tre, le chiese care anche ai non credenti, le insule magari urbanizzate ma fondamentalmente identiche a cinquecento anni prima, a trecento anni prima. Chioggia non cambia e non cambierà mai del tutto: duole anzi che ogni testimonianza non sia digitalizzata, se si eccettua la stele di Rosetta dei registri napoleonici al portale Antenati curato dal Ministero dei Beni Culturali, manna dal cielo per gli #ArchiveLovers di quasi ogni provincia. Come l’incendiario che si fa assumere dai vigili del fuoco, così il rovello di togliere la polvere alla Piccola Storia sta facendo considerare l’ipotesi di affrontare la scuola veneziana di archivistica, e ottenere col tempo i crismi per lavorare anche nella legacy: non prima di aver riportato anche qui gli eterni caratteri di laguna sud, e segnatamente quanto avvenuto nel periodo più che bicentenario intercorso fra i capistipite traslati sempre indietro nel tempo e mia nonna Lidia, l’ultima dei Surian.